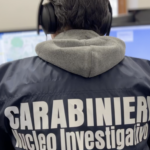Zelensky, il “re è nudo”. E Il timore è la Bomba
“Il re è nudo”. Volodymyr Zelensky ha perso la sua folle guerra. Le parole del Papa hanno strappato gli ultimi lembi del velo ipocrita che, sfilacciatosi mese dopo mese, già non riusciva più a nascondere la realtà di un conflitto in Ucraina tanto stupido quanto inutile, tanto sanguinoso quanto distruttivo. Sopravvivevano, infatti, nei media più che nell’opinione pubblica dell’Occidente la retorica bellicista, i toni velleitari, la sicumera di una vittoria che avrebbe fatto crollare regime e despota in Russia sotto il peso di tremende sanzioni economico-finanziarie e della riconquista di Crimea e Donbass. Ma qual è oggi il risultato? Vladimir Putin e il suo regime certamente autoritario vanno alle urne e affrontano gli elettori per rinnovare un conforto popolare che pur con un rivale come Alekseij Navalny, coraggioso ma con seguito relativo e localizzato nelle grandi città, non sarebbe mancato. Zelensky il voto deve invece rinviarlo a data da destinarsi, nonostante l’opposizione politica sia stata dispersa tra carceri e cimiteri e il dissenso sociale tacitato, perché sa che gli ucraini sono stanchi di una guerra che non è servita ad altro che a mietere centinaia di migliaia di vittime e terribili devastazioni.
L’aveva persa in partenza, la guerra, Zelensky. Fummo in pochissimi a prevederlo. Lo scontro non era, non è tra i figli e i nipoti della generazione decimata nell’Holodomor staliniano ed i figli e i nipoti dei caduti e reduci della “guerra patriottica”. Certo, regna ancora sovrano tra gli ucraini l’incubo dei sei milioni di condannati a morte per fame dal tiranno sovietico, come tra i russi è vivo il ricordo dei tanti ucraini che accolsero i nazisti come liberatori e parteciparono alla caccia agli ebrei e all’avanzata e poi alla difesa della ritirata della Wehrmacht. Ma questo era solo lo sfondo, non certo la scena. E oggi lo ammettono finalmente in tanti, tra coloro che guardano al futuro con gli occhi posati sul passato. E affiora, nelle stesse file dei fiancheggiatori del potere, dove il dubbio e dove ormai la certezza che il disegno cinico dei Neocon americani sia ancora una volta fallito: com’è avvenuto in Iraq e in Libia e in Siria e nelle ‘primavere arabe’ e in Afghanistan e nel Caucaso con l’esodo degli armeni dal Nagorno Karabakh sotto gli occhi chiusi dell’Occidente… Un elenco che sarebbe troppo lungo se sfogliassimo all’indietro le pagine della storia del Novecento.
Due lunghi anni, centinaia e centinaia di migliaia di vittime, devastazione oscena di città e di una natura con fiumi non ancora avvelenati e foreste non ancora cancellate dall’avidità distruttiva umana. Si è impiegato un troppo lungo biennio per arrivare alla conclusione che l’Ucraina ha perso, che la Russia s’è ripreso ciò ch’era suo ma che avrebbe lasciato a Kiev se la Nato avesse rispettato i patti, se non sciogliendosi come il Patto di Varsavia in mancanza di nemici in Europa, almeno contenendosi entro il confine tedesco; se non ci fossero stati il golpe a cavallo del 2014 a spingere Mosca al recupero della strategica Crimea; se il Donbass non avesse sofferto una sanguinosa repressione ma l’autonomia ch’era stata promessa , sottoscritta a Minsk e tradita; se i disegni di Washington e Londra non avessero infettato il desiderio di Kiev di entrare nell’Unione Europea aggiungendovi la prospettiva di porte aperte verso la Nato; se a Washington, a Londra e a Bruxelles non avesse, sulle ragioni della pace e della collaborazione internazionale, prevalso invece il timore (non certo nuovo) di un’alleanza tra Russia, Germania e Cina: energia, industria, produzioni e mercati in espansione .
Due lunghi anni e la prospettiva che le cose in Ucraina cambierebbero pur se rimanesse Biden alla Casa Bianca. Il preavviso nella cerimonia del ‘discorso alla nazione’ del presidente statunitense, dove a campeggiare è stata l’assenza della moglie di Zelensky, Olena, e della vedova di Navalny, Yulia: perché interpreti di visioni opposte sull’Ucraina. E il dubbio che se alla Casa Bianca ritornasse invece Donald Trump tutto muterebbe in poche settimane o forse giorni o addirittura una manciata di ore… il tempo di uno squillo sul ‘telefono rosso’ che collega Sala Ovale e Cremlino. Una telefonata poi accompagnata da quello che i diplomatici definiscono “un colloquio franco e fruttuoso tra leader che si rispettano”. Non più solo il Vecchio Continente ma ormai anche l’America è vieppiù stufa del velleitarismo di Zelensky: a preoccupare sono i confini meridionali attraversati negli ultimi anni da 10 milioni di clandestini e il crescendo di tensione tra le due superpotenze nucleari del pianeta .
Henry Kissinger suggerì un negoziato sperando che si snodasse sino al risultato di una tregua stabile su modello coreano. Vedremo se si riapriranno in Turchia le trattative riproposte da Recep Tayyp Erdogan, il quale si vede prossimo al commiato con il potere e vorrebbe assicurarsi un capitolo di storia. Finora manco una risposta. Anche il Papa ha invocato l’apertura di un negoziato e di risposte ne ha ottenute due, entrambe negative, da Kiev e da Washington. Però è arrivato inaspettato il ‘recupero’ – chissà se temporaneo – del ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba, che Zelensky voleva mettere da parte come ha fatto con il capo delle forze armate Valery Zaluzhny. Kuleba, che ha trascorsi e conoscenze italiane, s’è fatto notare per una replica al Pontefice più pacata e rispettosa di quella del presidente.
Che si sia reso conto, Kuleba, che a tirare troppo la corda si finisca per spezzarla? L’alternativa al negoziato è il protrarsi del conflitto ma con la prospettiva d’inviare in Ucraina truppe di Paesi Nato a rimpiazzare i combattenti pietrificati da un biennio al fronte e quanti sono fuggiti all’estero per evitare l’arruolamento. A fianco dei combattenti di Kiev vi sono già istruttori e ‘volontari’ occidentali. Ma l’invio ufficiale di militari dell’Alleanza Atlantica ha fatto rizzare i capelli alla diplomazia europea. L’ipotesi coltivata a Washington renderebbe di nuovo il Vecchio Continente possibile teatro di ‘primo fuoco nucleare’, col Trattato Inf in naftalina e il Nuovo Trattato Start in dubbio. Il ’primo fuoco’ in Europa, affidato a missili di corto e medio raggio, servirebbe a ritardare il ‘secondo fuoco’ (con missili intercontinentali che hanno come teatro d’impiego Usa e Russia), offrendo così un tempo supplementare al negoziato per evitarlo. Emmanuel Macron ha sbagliato tempi e calcoli, trasformando l’ipotesi in proposta. Ma nella stessa Francia, imbottita di nordafricani e mediorientali, gli elettori badano soprattutto a ciò che avviene a Gaza temendo l’ennesimo attentato palestinese o islamista. E fatta eccezione per Polonia e Paesi baltici, storici avversari della Russia, il resto dell’Europa s’è più o meno apertamente dichiarato contrario .
Fallita la strategia di ridimensionare la Federazione russa con una guerra convenzionale lunga e corrosiva, comincia a farsi strada la consapevolezza che superare certi limiti potrebbe spostare il confronto sul piano nucleare. E la Russia è il Paese con l’arsenale atomico più fornito. E’ proprio questa sua forza a testimoniare il suo ruolo di superpotenza militare non più sorretta da una pari forza armata convenzionale e da sempre monca di una significativa muscolatura economica che non sia quella che le offre con parto cesareo Madrenatura.
Un occhio ai numeri per capire meglio. La Russia conta infatti 5mila 889 ogive nucleari. Gli Stati Uniti 5mila 244, la Cina 500, la Francia 290, la Gran Bretagna 225, il Pakistan 170, l’India 164, Israele 90 e la Corea del Nord 30. Russia ed Usa sono definite le “ due superpotenze”. Ma nel giro di appena cinque-sei anni anche la Cina potrà essere considerata superpotenza, la “terza superpotenza” militare del pianeta. E a causa della guerra in Ucraina, Mosca ha stretto un’alleanza ‘per necessità’ con Pechino. La Cina assicura che è limitata alla sfera economica, ma chi potrebbe provarlo e assicurarlo per il futuro?
Un rapporto del Pentagono dello scorso autunno stimava un aumento considerevole dell’arsenale atomico cinese sviluppatosi nei precedenti tre anni: più che raddoppiato il numero delle testate nucleari – almeno 500 operative, cioè pronte all’utilizzo – e addirittura quintuplicato quello delle rampe terrestri di lancio dei missili intercontinentali, cosiddetti ‘strategici’ perché capaci di raggiungere distanze di 16mila km, praticamente qualsiasi obiettivo, che significa in grado di colpire gli Stati Uniti. Dalle rivelazioni del ministero della Difesa statunitense – note nella seconda metà di ottobre ma che si riferivano a rilievi ed analisi della primavera 2023 – si ricavavano alcuni dati significativi. Il primo: Pechino aveva abbandonato la ‘quiete’ dello stock atomico fatto registrare fino a circa il 2020 e moltiplicato le possibilità d’uso offensivo. Il secondo: nel solo ultimo anno le 400 testate del 2022 erano cresciute del 25%. Insomma, le oltre 200 ogive del 2020, divenute 400 due anni dopo, s’erano gonfiate fino alle 500 del 2023.
Le rampe di lancio terrestri, parimenti moltiplicate, assicurerebbero a Pechino la ‘spedizione’ di 350 missili intercontinentali. E questo incremento avveniva in concomitanza con i primi ostacoli all’espansionismo strategico della Cina che s’accompagnava a quello commerciale (favorito da una globalizzazione concepita con regole ad essa favorevole, nell’illusione occidentale che accelerasse una democratizzazione sulle orme di quella della Russia post-sovietica). Non a caso, la forza nucleare cinese è stata sviluppata assieme al potenziamento della Marina, che proietta l’espansionismo sui mari, verso territori non solo vicini ma anche oltre gli oceani. Non a caso, Washington presume che la fine della “stabilità” dell’arsenale atomico cinese – paragonabile fino a tre anni fa a quello della Francia – porterà entro la fine di questo decennio lo stock del Celeste Impero a 1000 testate, con un progressivo ulteriore aumento “almeno fino al 2035”.
Almerico Di Meglio
Share this content: